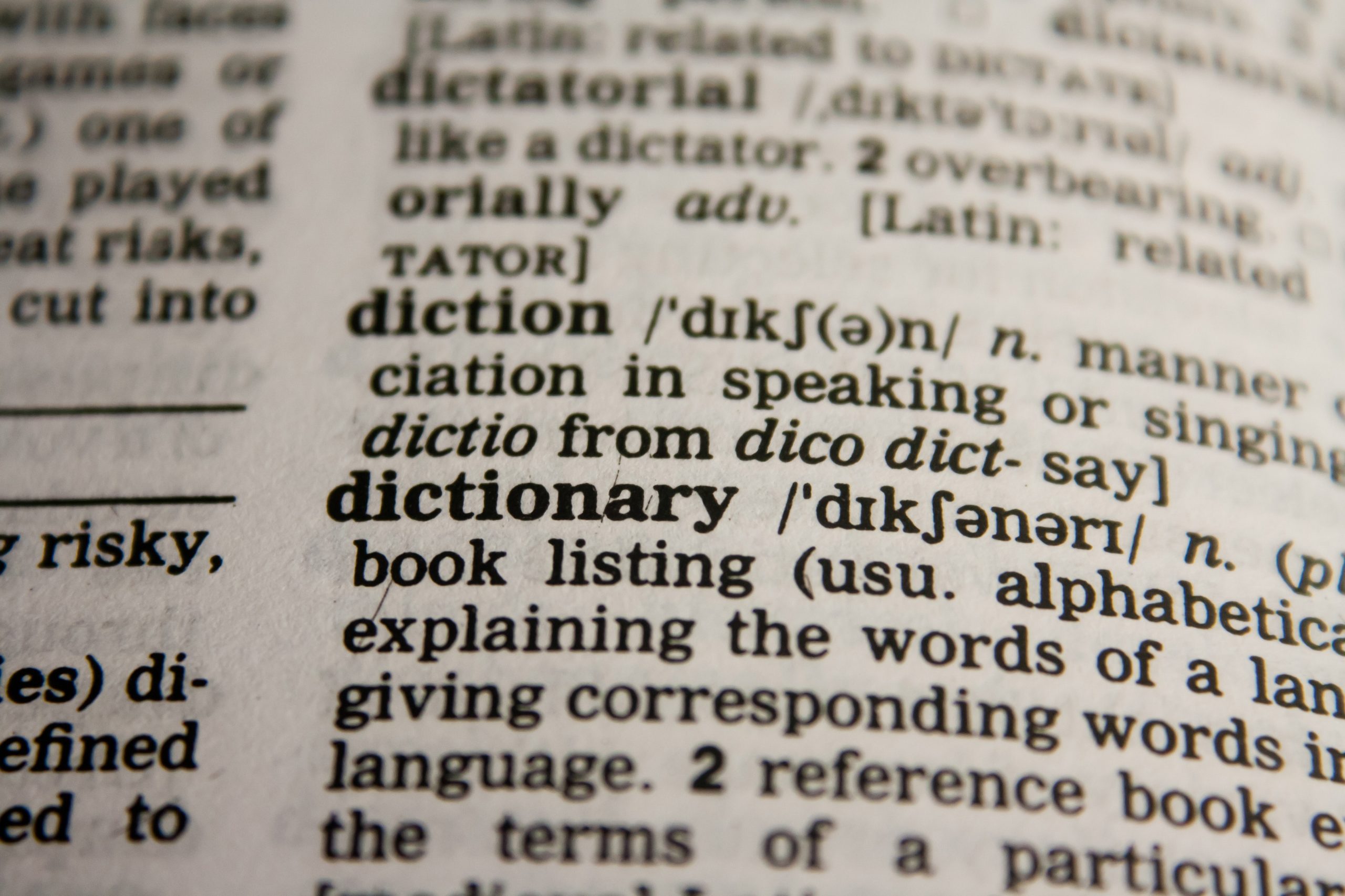Di cosa parliamo, quando parliamo di apprendistato? La domanda non è banale, anche a fronte del fatto che prendendo a riferimento la definizione fornita dal glossario del CEDEFOP l’apprendistato professionalizzante, che è poi la tipologia di apprendistato più diffusa in Italia, non rientrerebbe in questa categoria. Mappare e classificare le diverse definizioni di apprendistato presenti in Europa permette quindi di comprendere, da una parte, la logica con cui questi percorsi sono progettati e organizzati nei diversi Paesi, così come le finalità che intendono perseguire, e, dall’altra, di identificare possibili comuni tendenze evolutive, che contraddistinguono la diffusione dell’apprendistato in Europa. Un recente studio (J. Markowitsch, W. Wittig, Understanding differences between apprenticeship programmes in Europe: towards a new conceptual framework for the changing notion of apprenticeship, in Journal of Vocational Education & Training, 2020, pp. 1-23) va in questa direzione, con l’obiettivo di proporre un nuovo sistema di classificazione utile a comprendere similitudini e differenze tra i diversi apprendistati europei.
Seppur sia pacifico riconoscerne le origini “europee” nel periodo medievale, la grande difformità di percorsi che pur vengono così definiti nei diversi Paesi rende difficoltoso individuare una definizione univoca, tanto che gli stessi documenti comunitari parlano sempre di apprendistati, al plurale. Come dall’esperienza, uniforme, medievale, si è arrivati a questa frammentarietà? Gli autori del contributo ricordato notano due tendenze: il superamento della relazione (pedagogica) tra maestro e apprendista quale elemento centrale del percorso di apprendistato, e l’inclusione di quest’ultimo tra i contratti di lavoro nei diversi ordinamenti statali.
Caratterizzante l’apprendistato nel contesto medievale era la relazione tra maestro e apprendista, dove il secondo “rubava con gli occhi” le conoscenze del primo, e la dimensione formativa dell’esperienza lavorativa e del relativo contesto produttivo. La relazione formativa con il maestro è in seguito sostituita dal “principio di dualità”, cioè dalla presenza di almeno due, distinte, fonti di conoscenza: un soggetto formativo (scuola, centro professionale, università, agenzia privata, ecc..) e il luogo di lavoro. Con il tempo viene anche esaltata la natura contrattuale del percorso dell’apprendista, che diventa un “normale” lavoratore dipendente. Tutto ciò considerato, gli autori riconoscono che l’apprendistato inteso com’era nel periodo medievale ma anche dalle craft union industriali, come percorso cioè per l’ottenimento del riconoscimento di lavoratore qualificato (skilled), è oggi in declino. Quali, nuove, forme sta assumendo?
Quella in commento non è la prima analisi dedicata ad un tentativo di “classificare” gli apprendistati. I primi studi risalgono agli anni ’60 (realizzati dall’ILO), mentre una seconda generazioni di analisi risale agli anni ’80: ma tutti questi studi coprivano solamente pochi Paesi. Il primo studio autenticamente comparativo è stato condotto dal CEDEFOP nel 1995. In seguito, nuovi studi sono apparsi soprattutto dopo la crisi del 2008. Sono comunque due, principalmente, le categorie che possono essere adottate per raggruppare questi studi: quelli che si concentrano sulla governance del sistema apprendistato; e quelli che si concentrano su come si realizzano i processi di apprendimento nell’apprendistato. Il limite principale di queste pubblicazioni è il ragionare sviluppando una comparazione tra Paesi, e non tra singoli percorsi di apprendistato che, come appare chiaramente anche limitandosi al contesto italiano, possono essere molto diversi uno dall’altro, basti pensare alle differenze intercorrenti tra l’apprendistato “duale” (di primo e terzo livello) e quello professionalizzante (di secondo livello).
La classificazione proposta dagli autori prende quindi le mosse dall’analisi di 25 Paesi europei per un totale di 37 percorsi di apprendistato mappati, partendo dalla definizione di apprendistato fornita dal CEDEFOP, che richiede la contemporanea presenza di alcune caratteristiche: (1) una lunga durata, (2) un percorso formativo di alternanza tra un’impresa e un ente formativo; (3) una qualifica in esito riconosciuta a livello nazionale; (4) un contratto di formazione o di lavoro; (5) la presenza di una retribuzione o indennità. La banca dati utilizzata è quella realizzata dal CEDEFOP. Gli autori scelgono come criterio di analisi le “logiche formative” sottostanti i diversi programmi, cercando di integrare i due approcci precedentemente esposti (quello della governance e quello degli apprendimenti); queste logiche sono così definite: “modelli di credenze, norme e valori di base relativi a diverse aree e scopi dell’istruzione e della formazione”. Individuano quindi 4 diverse logiche: “(1) corporate training, (2) professional education, (3) school or university education (4) public training scheme as part of active labour market policy”, ognuna delle quali risponde a queste tre domande: qual è lo scopo della formazione? Chi ne definisce il contenuto? Come sono organizzati e finanziati gli apprendistati?
Professional education. Scopo centrale di questa logica è formare i giovani ai fini del loro inserimento in una comunità professionale, e per sviluppare le attività economiche di quest’ultima. Al centro sta quindi un’idea di “professione”, o “mestiere”, il cui contenuto è negoziato tra gli attori, in primis i datori di lavoro, gli stessi lavoratori, e le loro rappresentanze. Sono programmi che vedono un limitato intervento statale e che hanno come riferimento una comunità occupazionale e i relativi standard in termini di competenze. È il modello “tedesco” proprio del sistema duale, con l’esclusione dell’Austria.
Corporate training. Scopo di questa logica è formare i giovani alle competenze effettivamente richieste dalle aziende. È la singola impresa, in questi casi, a definire il contenuto della formazione. Le competenze ottenute sono quindi difficilmente trasferibili da un contesto lavorativo all’altro, perché altamente specifiche. Molti apprendisti hanno più di 25 anni, e a volte sono già dipendenti delle aziende: è un modello diffuso in USA e in altri Paesi extra-europei, ma che presenta anche assonanze con il sistema inglese e scozzese.
School or university education. Lo scopo in questo caso è la piena maturazione del cittadino attraverso la frequenza di un percorso scolastico o universitario. Il contenuto della formazione è solitamente definito da un ente pubblico. Sono scarsi i rimandi ad una “comunità occupazionale”. Lo Stato finanzia la realizzazione dei percorsi. In questa logica grande spazio è ricoperto dalla formazione school-based, il ruolo delle parti sociali è invece marginale. È il caso della Francia, ma anche dell’apprendistato “duale” italiano.
Public training schemes. L’apprendistato come “politica attiva” ha come scopo quello di aiutare i disoccupati o altri soggetti svantaggiati a migliorare le proprie competenze professionali e quindi potenziare la propria occupabilità. Il contenuto della formazione è definito da servizi pubblici per la formazione e l’impiego. Questi apprendistati sono finanziati dagli stessi contribuenti con le tasse sulla previdenza sociale. Sono quindi percorsi per i disoccupati o per i soggetti emarginati e svantaggiati, come le minoranze. A questa categoria appartiene (nella classificazione proposta) l’apprendistato professionalizzante italiano.
In conclusione, gli autori sottolineano come, dal loro punto di vista, vi sia in Europa una tendenza diffusa verso lo sviluppo e l’affermazione della logica “School or university education”. L’apprendistato, a partire dalla comparazione svolta, sembra cioè evolversi nella direzione di “ridursi” a modalità con cui possono essere realizzati i percorsi di apprendimento duale, al termine del quale è incoraggiato il proseguo degli studi a livello terziario. Ciò che forse manca, in questa analisi come in quelle ricordate, è un’idea di rappresentanza non appiattita al contesto industriale. Se infatti è condivisibile l’osservazione di chi denuncia il declino di un apprendistato finalizzato a formare “lavoratori qualificati” tramite lunghi percorsi completamente svolti sul luogo di lavoro – critica già avanzata da Adam Smith nel 1776 –, non altrettanto pacifica è l’osservazione che a questa dimensione è possibile ridurre il legame tra apprendistato e rappresentanza.
Quelle che vengono definite, anche dagli autori, “comunità occupazionali” sono in declino se si ragiona ancora in termini di “classe” o secondo le categorie ereditate dal secolo scorso: se invece si guarda a quegli studi che, anche recentemente, hanno evidenziato l’evolversi della rappresentanza verso una logica professionale mirante a promuovere la tutela dei lavoratori a partire dalla riconoscibilità delle loro competenze e dei loro titoli e qualifiche, allora si potrebbe anche ripensare il ruolo che, in questo orizzonte, può ricoprire l’apprendistato, integrando quindi – riprendendo la classificazione presentata – la prospettiva educativa e formativa con quella professionale. E questa integrazione, questa capacità cioè di far dialogare sistemi formativi – a tutti i livelli – e mondo del lavoro, con la costruzione di veri e propri profili “ibridi” connessi a chiari standard formativi e professionali, sembra essere un compito – e una sfida – che la stessa rappresentanza è chiamata a raccogliere.
ADAPT Junior Fellow